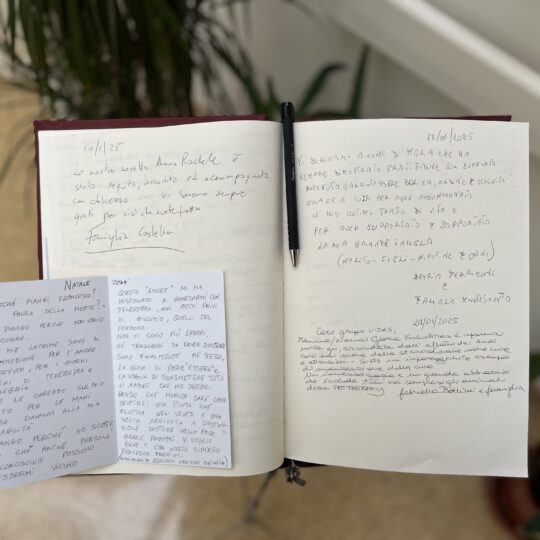Francesca Brandolini, psicoterapeuta e responsabile del Servizio di Psicologia di VIDAS, racconta l’importanza di prendersi cura anche di chi si prende cura.

Essere caregiver significa spesso assumere un ruolo totalizzante, che può mettere in discussione equilibri, relazioni e identità. Lo sa bene Francesca Brandolini, psicoterapeuta e responsabile del Servizio di Psicologia di VIDAS, che da anni affianca le famiglie nel percorso di cura.
In VIDAS, il servizio di psicologia è una presenza costante a fianco di pazienti e famiglie e il team oggi è composto da sei psicologhe e uno psicologo, presenti nei diversi ambiti di assistenza. “Negli anni il servizio è cresciuto – racconta Francesca – ma ho scelto di continuare a seguire anche alcuni pazienti a domicilio: è una dimensione che mi insegna ogni giorno quanto sia centrale la relazione, anche fuori dal contesto clinico.”
Indice
Il colloquio: un punto di ascolto dentro la complessità
I colloqui con i caregiver possono nascere in modi diversi. A volte è il primo confronto con l’assistente sociale ad aprire uno spazio di racconto. Perché questo “spesso è il primo momento in cui il caregiver riesce a esprimere fatica, rabbia, dolore, speranza. Se sente che esiste la possibilità di un supporto psicologico, può chiedere di essere seguito fin da subito”.
In altri casi, soprattutto a domicilio, sono i membri dell’équipe (medici, infermieri, OSS, fisioterapisti) a intercettare segnali di fatica emotiva e suggerire un supporto.
“Anche in hospice capita spesso che io stessa, passando tra le stanze, intercetti situazioni in cui c’è un bisogno inespresso o un forte bisogno di aiuto, allora propongo colloqui individuali o familiari, a seconda delle situazioni”, spiega Francesca. “Quando le dinamiche familiari sono complesse, proporre un colloquio può fare la differenza.”
Il carico insostenibile dei caregiver
Tra i temi che emergono con maggiore frequenza c’è quello del “caregiver burden”: un carico emotivo, fisico e mentale che può diventare insostenibile. “A volte il caregiver si sovraccarica, dimenticando completamente i propri bisogni. Altre volte si distacca, si disinveste, come forma di autodifesa”, spiega Francesca. “In entrambi i casi, il rischio è quello di rompersi.”
In sospetti casi di burden è importante prestare attenzione se nel racconto della persona emergono elementi che fanno pensare che ci sono problemi di sonno, un trasporto disfunzionale con il cibo, “ci sono persone che hanno smesso di mangiare o che mangiano troppo, fanno un utilizzo eccessivo di alcol, fumo, altre sostanze. La persona che si trova in una situazione di burden ha smesso di prendersi cura di sé anche dal punto di vista fisico, si ammala più facilmente o somatizza. Ha pensieri intrusivi, pensa che non ci sono vie d’uscita”.

Uno degli ostacoli principali è la difficoltà a chiedere aiuto: “Molti caregiver non si sentono legittimati a prendersi uno spazio. Pensano che non sia il “loro” momento per lamentarsi o per prendersi un momento di respiro. ‘Non posso lasciare mio padre per andare a fare un aperitivo con un’amica’, dicono. Ma in realtà riconoscere i propri bisogni e prendersi cura anche di sé è fondamentale, sia per sé stessi sia per la qualità della cura che si riesce a dare.”
“E bisogna prendersi cura di sé a partire da oggi, e non solo prima del punto di rottura, perché l’abitudine a farlo è qualcosa che si può mantenere nei momenti di fatica, nelle crisi più complesse”.
Altre volte, invece, si crea addirittura un attaccamento al ruolo di caregiver che diventa difficile da sciogliere. Prendersi cura di un genitore, infatti non è un’esperienza neutra: il significato che ciascuno le attribuisce dipende in larga misura dalla storia familiare e dalla relazione pregressa. “La convinzione di essere un bravo figlio – o figlia o sorella o moglie, visto che ancora oggi purtroppo si da per scontato che debbano essere le figure femminili a occuparsi dei famigliari – soltanto se ti prendi cura di un genitore è molto diffusa”, racconta Brandolini.
In alcuni casi, quel ruolo può diventare totalizzante. In alcune situazioni, il caregiver finisce per esercitare un forte controllo su tutta l’assistenza, arrivando a ostacolare perfino la volontà del paziente. “Per quella persona quel ruolo può aver rappresentato in alcuni casi l’unica occasione in cui ci si è sentiti finalmente riconosciuti in quella famiglia. Non è un comportamento sempre consapevole, ma nasce dalla difficoltà di lasciar andare”.
Dopo la cura: il tempo del lutto
VIDAS offre un servizio di supporto psicologico anche dopo la perdita, per aiutare i familiari a ricostruire un equilibrio. “Per chi ha vissuto anni nel ruolo di caregiver, è importante rielaborare ciò che è stato. Rielaborare il senso di colpa, il dolore, ridefinire la propria identità e dare un nuovo significato a quanto vissuto è essenziale per ritrovare il proprio equilibrio. E’ un processo che richiede tempo e attenzione.”
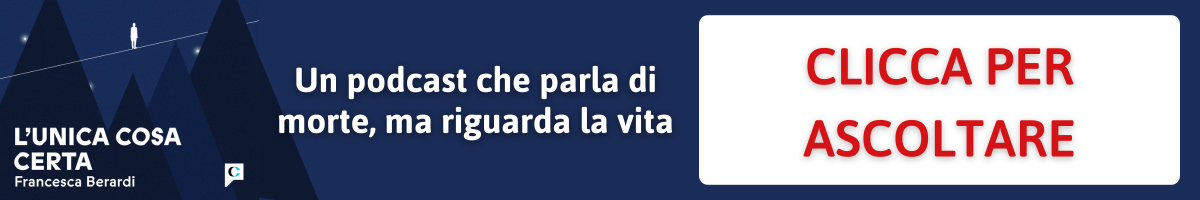
Anche il cambiamento dei ruoli familiari può essere fonte di grande sofferenza ed è uno degli elementi più delicati da affrontare. “Un figlio che diventa il caregiver del proprio genitore deve fare i conti un capovolgimento difficile da accettare. Non si tratta di cancellare il disagio, ma di aiutare le persone a mantenere un filo di continuità tra chi erano prima e chi sono oggi, nonostante il cambiamento fisico della persona assistita.”
Come nel caso di una donna che, mentre diventava mamma per la prima volta, ha trovato un modo per coinvolgere la madre gravemente malata nei preparativi per la nascita del bambino. “Attraverso piccoli gesti, come scegliere insieme il corredino, è riuscita a mantenere viva la relazione madre-figlia che avevano prima,” racconta Francesca con un sorriso.
Persone, non ruoli
Nei colloqui il lavoro degli psicologi VIDAS mira a far emergere i bisogni autentici, i silenzi, le emozioni non dette. “A volte basta creare uno spazio sicuro per aiutare le famiglie a riconoscere la fatica reciproca, a dirsi ‘grazie‘. È un passaggio semplice all’apparenza, ma potentissimo.”
E per chi racconta i caregiver – giornalisti, comunicatori, medici, volontari – Francesca condivide un invito alla cura:
“Ricordiamoci che il caregiver è prima di tutto una persona, con una storia, dei sogni, delle passioni. Non riduciamolo al suo ruolo. Guardarlo davvero è il primo passo per aiutarlo a sentirsi visto e compreso.”